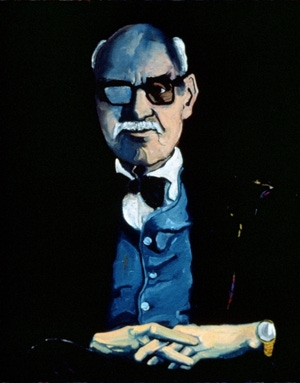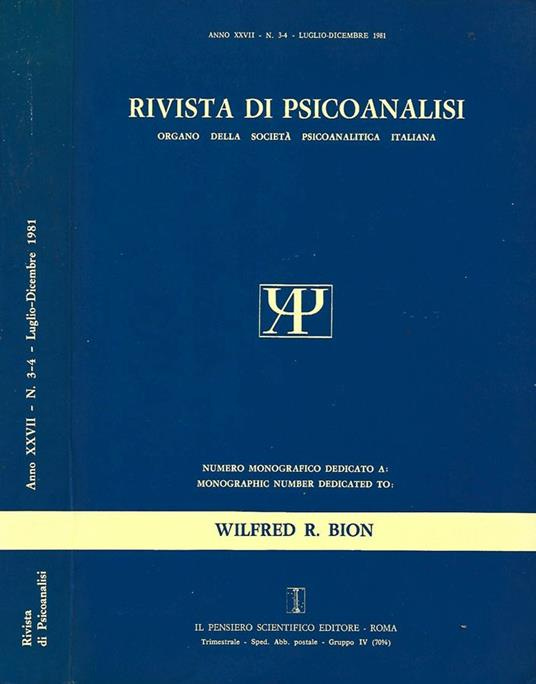INVITO A BION
La teoria sulla nascita del pensiero dello psicoanalista inglese e uno scritto di Mauro Mancia del 1981 sul sonno e sul fenomeno delle "illusioni ipnagogiche" (riletti alla luce della teoria di Bion)
Abbiamo scritto in precedenza su Bion, psicoanalista di provenienza indiana e naturalizzato inglese.
Bion iniziò tardi la sua carriera da psichiatra e psicoanalista: i primi anni lo videro impegnato in altri studi (storia), oltre ad essere caratterizzati dallo scoppio delle due guerre mondiali, che lo psicoanalista conobbe prima da soldato civile, poi da medico militare (e da osservatore attento: risalgono a quegli anni le sue intuizioni sui conosciuti “assunti di base”).
Questo post raccoglie alcuni contenuti che, della teoria di Bion, forniranno alcuni punti fermi, aspetti della sua teoria che non possono essere trascurati. Qui di seguito un brevissimo indice dei contenuti:
PRIMA PARTE: un approfondimento sulla teoria sulla nascita del pensiero di Bion, e spunti dal lavoro di Antonino Ferro
SECONDA PARTE: riportato per intero, un articolo del 1981 (inedito in rete) scritto da Mauro Mancia, uno dei padri della neuropsicoanalisi italiana, che scrisse questo contributo tentando di raccordare gli aspetti teorici bioniani con quello che -al tempo- si sapeva di neuroscienza del sonno
PRIMA PARTE
La teoria sulla nascita del pensiero
Il pensiero di Bion ci fornisce una spiegazione di quelli che sono i meccanismi alla base dei processi di pensiero.
Secondo l’autore il pensare risulterebbe da una corretta trasformazione di impressioni sensoriali, gli elementi β, in elementi di maggiore complessità che definisce elementi α.
Nel caso in cui esista una difficoltà a metabolizzare (“digerire”) queste informazioni sensoriali, ne risulterà alterata la capacità del paziente di costruire pensieri; una difficoltà del progetto trasformativo, cioè da β a α (Bion, 1962) produce l’impossibilità di creare immagini mentali dotate di senso e fondamentali per la salute mentale del paziente, nonché di creare un “testo narrativo” comprensibile agli altri.
Scrive Antonino Ferro:
“Secondo Bion è centrale l’attività di metabolizzazione che noi facciamo di qualunque afferenza percettiva: questa attività consiste nella formazione a partire dalle afferenze sensoriali di un pittogramma, o ideogramma visivo: una immagine poetica che sincretizza la risultante emotiva di quell’afferenza o di quella sommatoria di afferenze: l’elemento α”.
Gli elementi β
Bion teorizza che all’origine dei processi di pensiero vi sia una quota di elementi derivati dagli organi di senso che viene “digerita” dalla mente per creare pensieri sani e gestibili.
Questi elementi, che il famoso psicoanalista chiama elementi β, sono definiti in termini di protoemozioni e protosensorialità.
Esiste cioè un livello primitivo di modalità di rapportarsi al mondo esterno basato su sensazioni ed emozioni non ancora gestite e non gestibili.
Si può parlare in un certo senso di materiale emotivo alla stato grezzo che ha un grande impatto nel caso in cui arrivi alla coscienza non metabolizzato: Bion attribuisce la causa scatenante di molte patologie all’ “evacuazione” e ad un’ “iperpresenza” di elementi β.
Secondo questo modello è possibile per esempio pensare all’attacco di panico come ad un’evacuazione (eruzione) di elementi β o aggregati di elementi β non digeriti (i betalomi) che inondano in modo devastante la mente.
In quest’ottica le sindromi ipocondriache andrebbero pensate come un continuo bisogno da parte del soggetto di “tenere sotto controllo” un substrato psichico ritenuto pericoloso poiché composto principalmente da elementi β non digeriti.
Antonino Ferro, tra i maggiori studiosi del pensieri di Bion in Italia, paragonerà l’ondata devastante di elementi β che caratterizza l’attacco di panico alla:
“[…] Massa gelatinosa dello straordinario film The Blob di Yerworth del 1958, nel quale per l’appunto una massa gelatinosa caduta sulla terra da un frammento di asteroide inizia a divorare tutto aumentando sempre più di dimensioni”.
Tornando al pensiero di Bion, è fondamentale riprendere il concetto di accensione mentale; secondo lo psicoanalista è necessario che la capacità di metabolizzare elementi β venga accesa attraverso la relazione con un’altra mente:
“[…] Solo così è consentito l’innesto del meccanismo elementi β evacuati in elementi β accolti e restituiti trasformati in elementi α, ma soprattutto arricchiti da quote di “alfità”, che in sequenza consentiranno l’accendersi della funzione α autonoma“
Gli elementi α
Nella definizione di Roche Barnos (2000), l’elemento alfa potrebbe essere pensato come “l’elemento protovisivo del pensiero che indica l’avvenuta trasformazione di ciò che urgeva come β in pittogramma visivo”.
In altre parole quando un elemento protoemotivo allo stato grezzo viene digerito dalla funzione α assume finalmente una forma comprensibile al soggetto e quindi comunicabile. Il processo di trasformazione che porta l’elemento β a essere “comunicato” in quanto elemento α è graduale: termina nel momento in cui viene scelto un particolare derivato/dispositivo narrativo per poterlo “leggere”.
Secondo la teoria di Bion la difettosità del processo di pensiero può essere riscontrata in due loci patologici: può esservi una carenza nella capacità della mente di produrre elementi α (la funzione α), oppure, nel caso in cui quest’ultima risulti integra, può mancare la capacità di leggere e riconoscere in modo corretto gli elementi α prodotti.
In questo secondo caso gli elementi β vengono trasformati in α ma poi sono difettuali gli elementi che su questi devono lavorare.
In una mente “sufficientemente sana” (va ricordato che per Bion una mente sana è stata “creata” dalla relazione con un’altra mente-madre) gli elementi protoemotivi vengono assimilati e digeriti fino a diventare gestibili e chiari al soggetto, insomma si trasformano in pensieri.
Nel momento in cui gli elementi α sono stati creati devono essere riconosciuti dalla mente per la loro forma ed elaborati fino a diventare ciò che Antonino Ferro definirà derivati narrativi.
L’elaborazione dell’elemento α può essere rappresentata come una progressiva raffinatura a partire dall’elemento β: si pensi a un vissuto primordiale di rabbia e vendetta (β) che trovi la sua prima elaborazione nel pittogramma narrativo “piscina piena di sangue”. Da qui l’elemento α subirà ulteriori trasformazioni fino a poter essere narrato attraverso “film differenti”, i derivati narrativi.
Se l’apparato per elaborare e leggere gli elementi α, definito da Bion apparato per pensare i pensieri , è difettoso, ci saranno situazioni cliniche
“[…] Borderline, narcisistiche in cui c’è una funzione α adeguata ma i cui prodotti non sono poi gestibili e l’interpretazione classica genera spesso più persecuzione che crescita”.
Esistono patologie quindi dovute a una difettosità della funzione α, quella cioè deputata a metabolizzare gli elementi β, oppure a una difettosità della lettura del prodotti di questa funzione.
Un terzo fattore patogenetico può derivare tuttavia da una sovrabbondanza di elementi β rispetto alla capacità lavorativa della funzione α.
Esistono cioè situazioni in cui la quantità di stimolazioni sensoriali ed estero-propriocettive supera la quantità solitamente gestibile dalla mente; queste situazioni sono definite “da accumulo” o più comunemente situazioni traumatiche.
Nel momento in cui esista una quota di elementi β che non può essere gestita vengono messi in atto dei meccanismi difensivi volti a salvaguardare l’integrità psichica della mente. É possibile che una certa quantità di elementi β venga messa in attesa di una funzione α che li elabori: questi sono stati definiti da Ferro elementi balfa, oppure è possibile che vengano messi in atto meccanismi di difesa più comuni, come il diniego, la negazione o la scissione (la quota di elementi β viene scissa e proiettata via).
Secondo la teoria di Bion elementi α vengono prodotti di continuo e in sequenza: durante il sonno si renderanno accessibili attraverso le immagini del sogno, durante la veglia come si vedrà emergeranno attraverso pittogrammi, flash visivi o derivati narrativi.
Per chiarificare il concetto bioniano di trasformazione β -> α Ferro utilizzerà una metafora suggestiva:
“Se usassimo delle tesserine tipo quelle del Memory, una sequenza potrebbe essere fiore-ciliegia-zanzara e, ad esempio, starebbe a pittografare una esperienza gradevole quindi gustosa per divenire poi vagamente irritante”
L’elemento α che viene prodotto è accessibile nella sua forma primaria (non elaborato né “derivato”) solo in due particolari situazioni:
nel caso in cui esso fuoriesca dall’apparato che deve contenerlo e venga visto all’esterno del soggetto (per esempio il paziente vedrebbe un fiore o una ciliegia che esprimerebbero come si sente in quell’istante). Questo fenomeno è descritto come flash visivo.
nel caso in cui il soggetto sia capace di entrarvi in contatto grazie alla sua capacità di rêverie.
La capacità di rêverie è stata definita da Bion come la capacità caratteristica della madre di introiettare gli elementi β del bambino e di metabolizzarli per lui restituendogli elementi α (in questo modo si accende la mente del bambino).
Tale capacità, se introiettata dal bambino, gli garantirà un adeguato funzionamento mentale poiché gli sarà concesso di visualizzare negli elementi a la parte più autentica di sé. Si può notare quindi come la formazione della mente sia pensata da Bion in chiave fortemente relazionale.
L’apparato per pensare i pensieri
Facendo riferimento allo schema che riassume le basi concettuali del pensiero di Bion, si noterà che l’autore ha teorizzato la presenza di un apparato volto a elaborare gli elementi α già metabolizzati: lo definisce apparato per pensare i pensieri.
Si tratta di un secondo livello nel processo di produzione del pensiero narrativo, cioè del pensiero che può essere espresso e narrato a sé e agli altri.
Questo apparato è caratterizzato da una negoziazione continua a livello di significato attribuito agli elementi α in entrata: i suoi prodotti sono i derivati narrativi (Antonino Ferro sosterrà che da uno stesso elemento a possono originarsi più derivati narrativi – “racconti” – che a livello di significato emotivo hanno la stessa valenza).
I derivati narrativi, che assumono come si vedrà in seguito forme diverse (derivati narrativi ludici, grafici, etc.) sarebbero per Bion i pensieri nella loro forma normale e al loro stato più “raffinato”.
É impossibile pensare che all’interno del campo d’analisi il terapeuta non metta in gioco la sua capacità di elaborare o trasformare in un certo modo il materiale psichico che lo coinvolge in quel frangente; nella seduta l’analista utilizzerà il suo apparato per pensare i pensieri nel modo in cui gli sarà congeniale partendo da quanto gli proviene da altre fonti emozionali significative.
Può accadere che le capacità elaborative del paziente superino quelle dell’analista e questo ne risulti influenzato a livello di apparato per pensare i pensieri (situazione di inversione del flusso degli elementi α): secondo Ferro “questo fa parte a pieno diritto delle regole del gioco psicoanalitico“.
L’apparato per pensare i pensieri funziona a livello cosciente, le aperture a significati differenti dipendono da situazioni di oscillazione tra momenti schizoparanoidi e depressivi in termini kleiniani (PS↔D) e oscillazioni tra momenti di contenimento e momenti di fuoriuscita delle emozioni. Da queste oscillazioni dipende la scelta di un significato narrativo da attribuire all’elemento a, secondo un meccanismo vicino ai concetti piagetiani di assimilazione e accomodamento (nel senso di ridefinizione del significato e accostamento a un senso nuovo: l’“irrompere del fatto prescelto” secondo Bion).
Il sogno della veglia
Si delinea così per Bion una modalità di funzionamento della mente con risvolti altamente creativi, per cui da un elemento emotivo grezzo possono prendere vita molte differenti immagini mentali ognuna con un suo “dialetto”.
É questo ciò che l’autore definisce pensiero onirico della veglia, intendendo che l’attività di produzione di elementi da parte della funzione α può essere accostata a quella di produzione di immagini oniriche durante il sonno; vi è quindi un onirico della veglia, e un onirico nel sonno.
É da sottolineare che già la concezione di sogno per Bion era differente da quella classica freudiana, poiché se Freud considerava il pensiero onirico come una trasformazione di materiale inconscio, secondo Bion anche il materiale conscio viene elaborato dal lavoro-del-sogno, per poter venire immagazzinato e selezionato.
Quindi, secondo l’autore, il lavoro-del-sogno (pensiero onirico) lavora incessantemente durante la veglia come durante il sonno.
L’inconscio nel pensiero di W. Bion
Il concetto bioniano di inconscio si differenzia da quello teorizzato nella letteratura classica: è grande l’attenzione data dall’autore alla lettura relazionale delle dinamiche psichiche anche a livello inconscio. Freud teorizzava l’inconscio come costituito da materiale rimosso durante l’infanzia, o a seguito di avvenimenti fortemente traumatici. Durante la seduta psicoanalitica era necessario riportare alla luce questa verità “sepolta e preesistente” al fine di rendere chiara al paziente l’origine storica della sua nevrosi. L’inconscio era visto quindi come fortemente condizionato dal passato e accessibile solo attraverso l’analisi del sogno o la lettura analitica dei sintomi (paraprassie, lapsus, conversioni isteriche, etc.).
La visione che ne dà Bion invece considera l’inconscio come frutto della trasformazione operata dalla funzione α: l’inconscio è per l’autore formato da sequenze di elementi α non accessibili alla coscienza (va ricordato che l’elemento α nella sua forma pura è visualizzabile solo nel flash visivo o attraverso la rêverie). Anche qui è d’aiuto per la comprensione la metafora delle carte Memory utilizzata da Antonino Ferro:
“[…] Man mano che vengono costruiti questi elementi possono rimanere, come in immaginario Memory, scoperte e formano il sistema della coscienza, o capovolti e formano il sistema inconscio. Cioè, l’inconscio di Bion non è un a-monte, ma è un a-valle dell’incontro dell’elemento β con la funzione α”.
Com’è intuibile questo mette in crisi il concetto classico di analista come “archeologo”, che dalla nascita del concetto di campo d’analisi bipersonale era risultato vacillante: si parla in questo caso di un inconscio creato dal soggetto attraverso la funzione α, non di un soggetto pilotato nelle sue scelte dal suo inconscio, in modo “quasi” deterministico.
SECONDA PARTE: MAURO MANCIA SU BION
La letteratura su Bion è ampia e articolata: vogliamo qui pubblicare per intero un articolo del 1981 contenuto all’interno di un numero monografico della rivista di psicoanalisi dedicato proprio a Bion (immagine sopra).
Questo volume raccoglie molti contributi a proposito di diversi aspetti teorici della teoria di Bion: quello che qui pubblichiamo è una riflessione estremamente attuale su un tema che -al tempo- doveva sembrare particolarmente avanguardistico, gli intrecci tra la teoria di Bion e la neuroscienza del sonno.
Bion coniuga in sé paradigmi che ancora oggi in psicoanalisi si alternano: il paradigma pulsionale e quello relazionale; la sua idea era che la mente si costruirebbe, per prima cosa, in seno a un assetto relazionale, con il caregiver (la madre o il padre, o chiunque altro) in una posizione di contenimento “totale”, in grado di fornire quella che aveva chiamato rêverie, una posizione cioè di contenimento di qualunque pulsione/bisogno/proiezione giunga dal neonato.
Bion sosteneva che nei primi anni, nel periodo pre-linguistico e pre-cognitivo, la mente del bambino sarebbe abitata da “rappresentazioni” di sensazioni, elementi di proto-pensiero e proto-emozioni, materiale emotivo grezzo, che definì l'insieme degli “elementi beta”.
Sarebbe stato il seguente “passaggio” relazionale, l'alternarsi di scambi relazionali con la o le figure/e di accudimento, a rendere possibile una raffinatura di quegli elementi β, evacuati dal bambino, "masticati e digeriti psichicamente” dalla “madre/contenitore” e re-inviati “al mittente”, a rendere possibile la nascita della mente del bambino.
Uno degli spunti più incredibili che Bion ci ha fornito, è relativo alla strutturazione della mente: gli elementi β elaborati e raffinati, re-introiettati dal neonato, dal suo punto di vista si sarebbero addensati in una “pellicola”, una barriera di elementi alfa (la versione elaborata degli elementi β), che sarebbe andata a creare la barriera che separa il conscio dall’inconscio negli esseri umani.
Bion la chiamò “barriera di contatto” e ne parla in “Apprendere dall’esperienza”:
“la funzione alfa dell'uomo, sia nel sonno che nella veglia, trasforma le impressioni sensoriali aventi rapporto con una esperienza emotiva in elementi alfa che, mentre proliferano, si condensano formando la barriera di contatto. Questa barriera che è quindi in continuo processo di formazione, segna il punto di contatto e di separazione fra gli elementi consci ed inconsci e genera la distinzione fra loro“
Dal suo punto vista, cioè, l'inconscio sarebbe separato dal coscio da una “catena” di elementi emotivi elaborati e simbolizzati/processati dalla mente, il che da un lato ci fa pensare alle teorie di Lacan nel suo periodo strutturalista -con la catena di significanti funzionale a evocare i significati da essi stessi sottesi-, dall'altro rende molto facile agganciarci all’articolo che di seguito riportiamo, relativamente alla domanda: “che fine fanno gli elementi beta non simbolizzati e non mentalizzati”?
Nell'articolo che in seguito riportiamo, Mauro Mancia si spinge a interpretare il fenomeno delle illusioni ipnagogiche come “eruzioni” di elementi β, e legge la neuroscienza del sonno alla luce della teoria di Bion. Tenta poi un parallelismo tra alcuni elementi teorici di Bion più controversi (come la “griglia”) e alcuni altri aspetti biologici.
La potenza del modello di Bion, come è stato per tutti i grandi maestri, è la sua plausibilità, la sua relativa semplicità e l’uso di metafore e immagini chiare per tentare di leggere il funzionamento della mente.
Per chi volesse avventurarsi nella lettura di Bion, questo libro può rappresentare un buon punto di partenza.
Buona lettura!
Rilevanza neurobiologica di alcuni modelli proposti da W.R.Bion
di Mauro Mancia, 1981
Questo mio breve intervento vuole essere una integrazione alla teoria della funzione alfa di Bion nella veglia e nel sogno. L'ipotesi etologica, (Timbergen, 1951) confermata da numerosi dati neurofisiologici (Mancia, 1975, 1976, 1980) che il sonno possa essere considerato una forma di istinto, radicata quindi nella vita pulsionale dell'individuo e attivata dall'energia che risiede nell'inconscio, dove fasi preparatorie o appetitive si alternano ritmicamente a fasi consumatorie, permette un approccio pluridisciplinare al fenomeno sonno-sogno e dà alla psicoanalisi gli strumenti per una integrazione delle conoscenze derivanti dalla pratica clinica e per un arricchimento delle teorie che Freud (1900) ha proposto nella Interpretazione dei Sogni.
Non è qui la sede per puntualizzare le conferme e le smentite che la moderna eto-neurofisiologia ha portato alla teoria di Freud.
Molte delle conferme sono state clamorose come quella relativa alla universalità biologica, almeno fino agli uccelli, di quello stadio che nell'uomo è correlato con i sogni e alla necessità di questo particolare stadio REM parallelo all'attività mentale di tipo onirico, per una normale crescita e vita mentale o, perfino, per la stessa vita biologica.
Mi interessa invece in questa sede, dedicata al pensiero di Bion (1963, 1965) e alla rilevanza biologica di alcuni suoi modelli nati dalla esperienza della psicoanalisi, mettere in relazione alcuni aspetti delle sue teorie ed i contributi più recenti che la eto-neurofisiologia e la psicologia sperimentale hanno portato in tema di attività mentale correlata con quegli eventi biologici che si definiscono sonno non-REM, nelle sue fasi 1,2, 3 e 4 e sonno REM nei suoi vari e complessi aspetti somatici e vegetativi (Mancia, 1980).
Un punto di rilievo del pensiero di Bion, che mi appare centrale al discorso che stiamo facendo, riguarda un aspetto che potremmo definire di tipo « interazionista » della sua teoria e cioè che la funzione alfa, come funzione della mente, ha tra l'altro, il compito di trasformare in elementi alfa, che appartengono ancora al sistema della mente, le esperienze sensoriali e motorie che entrano nel dominio della neurofisiologia e utilizzarle per la formazione del pensiero che rientra a sua volta ancora nelle funzioni della mente. Ma il pensiero di cui si occupa Bion è correlato alla veglia e a fasi di sonno che rappresentano funzioni alla cui base operano processi di comunicazione nell'ambito di circuiti operativi che interessano specifiche e definite, nelle loro modalità, strutture del cervello.
Dunque Bion avanza, sulla base delle sue esperienze cliniche, una ipotesi sul problema mente-cervello che, nonostante il percorso teorico diverso, si riallaccia direttamente al primo pensiero di Freud, quello del « Progetto » (1895) e al suo dualismo che potremmo considerare di tipo interazionista (Popper e Eccles, 1977).
Se leggiamo con attenzione « Apprendere dall'Esperienza», notiamo molte idee che si fondano su convinzioni di tipo interazionista dove la funzione del pensiero, intesa come funzione alfa della mente, interagisce, riassumendone e interpretandone aspetti essenziali, con una funzione di natura neurofisiologica. « Il bambino che prova quell'esperienza emotiva che chiamiamo imparare a camminare - scrive Bion - è in grado, mediante la funzione alfa, di immaginare tale esperienza, pensieri destinati un tempo a diventare coscienti divengono inconsci di modo che il bambino può pensare tutto quanto è indispensabile a camminare senza doverne essere più cosciente » (Bion, 1965, pag. 31). Ma l'esperienza di imparare a camminare è anche una straordinaria esperienza neurofisiologica senso-motoria che parte da complesse strutture specializzate, interessa circuiti facilitatori e inibitori, questi ultimi a tipo di feedback e di feed-forward che modulano la facilitazione e la definiscono nel suo spazio e nel tempo e si basa sulla integrazione di informazioni che provengono dal vario mondo dei recettori periferici. La progressiva formazione di nuove sinapsi nella corteccia senso-motoria, nel cervelletto e in altre strutture sottocorticali, la mielinizzazione di fibre nervose e la organizzazione di circuiti operativi nel sistema nervoso centrale costituiscono gli elementi fondanti l'esperienza neurofisiologica su cui si struttura progressivamente la esperienza emotiva di imparare a camminare e la trasformazione del « pensiero » relativo a quella funzione. Una interazione mente cervello che coinvolge le funzioni alfa del pensiero vigile, da una parte, e le funzioni di circuiti nervosi specializzati per la organizzazione della coordinazione motoria, dall'altra.
Ma l'interazione che, in modo più definito traspare nel pensiero di Bion, riguarda la teoria della funzione alfa nel sogno, teoria che permette una correlazione dell'attività mentale nel sonno con la organizzazione delle varie fasi descritte sulla base di rilievi neurofisiologici. Scrive Bion (1965, pag. 41) « chi dorme ha un'esperienza emotiva, la converte in elementi alfa e diventa in tal modo capace di pensieri onirici ».
É noto che i meccanismi della veglia e dell'attenzione e l'inizio della caduta del livello di queste funzioni neurofisiologiche fino all'addormentamento e al sonno con le sue fasi, sono affidate rispettivamente a sistemi desincronizzanti e sincronizzanti sebbene, paradossalmente, sono proprio i sistemi desincronizzanti che dominano nella fase di sonno REM che appare come la più significativa sul piano dell'esperienza mentale.
La funzione alfa della veglia e del sonno-sogno non è compatibile altro che con la prevalente messa in opera dei sistemi desincronizzanti affidati a strutture reticolari mesencefaliche e a circuiti reticolo-talamo-corticali nella veglia e a circuiti a partenza pontina nel sonno REM (vedi Moruzzi, 1972, Mancia, 1980). L'attivazione dei sistemi sincronizzanti che coinvolgono circuiti ipotalamo anteriore-reticolare caudale-talamo mediale-corteccia coincide con il progressivo restringimento del campo di coscienza, la perdita di funzione alfa, il dissolversi della barriera di contatto, la comparsa di elementi beta e la disintegrazione del pensiero.
Poiché la nostra mente opera, in modo ottimale, durante la veglia e nell'attenzione, entro un « range » specifico per ciascun individuo che presuppone un perfetto equilibrio funzionale tra i sistemi desincronizzante e sincronizzante sopra descritti, è possibile che la prevenzione di un eccesso di veglia e di attenzione così come quella di una loro eccessiva diminuzione sia affidata ad una organizzazione a feed-back che permetta l'aggiustamento di queste funzioni ad un livello di base. Intorno a questo livello potranno esserci oscillazioni che rappresenteranno la base neurofisiologica delle fluttuazioni della nostra attenzione della veglia e delle funzioni del nostro pensiero. Questi circuiti operativi sono anche quelli che costituiscono la cornice biologica nell'ambito della quale può esplicarsi la funzione alfa.
Nel sonno questo equilibrio viene alterato.
All'addormentamento l'acuta deafferentazione sensoriale per ridotto input e per inibizione attiva delle vie sensoriali favorisce i sistemi sincronizzanti che faciliteranno il processo di trasformazione a carattere disorganizzato o destrutturante della realtà sensoriale e la formazione degli elementi, che Bion chiama beta, non idonei per pensare e, a questo stadio, neanche per sognare, ma che possono essere in parte evacuati lungo i canali della sensorialità (le allucinazioni ipnagogiche) o della motricità (le mioclonie ipniche fisiologiche) e in gran parte andranno incontro a trasformazione in elementi alfa e quindi in funzione alfa capace di formare il pensiero del sogno.
Il passaggio dalla veglia alle diverse fasi del sonno, caratterizzato da una sempre maggiore attività dei sistemi sincronizzanti rispetto ai desincronizzanti, è anche il momento in cui, secondo il modello di Bion così come io l'ho interpretato si può ipotizzare una dissoluzione della barriera di contatto, cioè di quella funzione di separazione tra conscio e inconscio, tra realtà e sogno. É la dissoluzione di questa barriera a fornire gli elementi per la formazione di uno schermo beta, elementi che dovranno subire, nel corso del sonno, e in fase REM, una trasformazione in elementi alfa. Per Bion « la capacità di sognare », cioè di fare questa trasformazione, « preserva la personalità da uno stato virtualmente psicotico », mentre la psicosi si caratterizza per una incapacità a sognare. Una incapacità a sognare è presente anche negli stati confusionali, in cui la mente è dominata da uno schermo beta, con elementi beta che non possono essere trasformati e che portano a fondere insieme, confondere cioè conscio e inconscio. Ci sono evidenze (Mancia D. e coll., 1978) in favore dell'ipotesi che questo delicato processo di dissoluzione della barriera avvenga nelle fasi I e II non-REM.
Le successive fasi III e IV sono popolate dagli elementi beta che derivano da questa dissoluzione. Sarà poi su questi elementi che verrà a strutturarsi in fase REM la trasformazione in funzione alfa e la costituzione di una nuova barriera di contatto. Qui vorrei riferirmi al cap. VIII di « Apprendere dall'esperienza » dove Bion sembra precisare la relazione che la barriera di contatto ha con il pensiero del sogno. Egli dice « la funzione alfa dell'uomo, sia nel sonno che nella veglia, trasforma le impressioni sensoriali aventi rapporto con una esperienza emotiva in elementi alfa che, mentre proliferano, si condensano formando la barriera di contatto. Questa barriera che è quindi in continuo processo di formazione, segna il punto di contatto e di separazione fra gli elementi consci ed inconsci e genera la distinzione fra loro ». La mia interpretazione del pensiero di Bion in questo punto è che nella mente si abbia, a seconda delle varie fasi di sonno o di veglia, un continuo processo di formazione-dissoluzione della barriera di contatto. « La natura della barriera di contatto - precisa Bion - dipenderà dalla natura del rifornimento di elementi alfa e dal tipo di relazione che sussiste fra loro ». Nel ciclo sonno-veglia la formazione di una nuova e specifica barriera di contatto è parte del lavoro onirico che si realizza in modo specifico nel sonno-REM. Esso consiste essenzialmente in a) organizzazione degli elementi alfa in funzione alfa e formazione di una barriera di contatto, diversa da quella della veglia; b) attribuzione di una componente percettiva tesa a colmare la mancanza dell'oggetto, cioè l'allucinazione e l'autorappresentazione; c) attribuzione di un ordine logico e geometrico agli elementi sparsi e incoordinati, che darà il senso del sogno, cioè il suo significato latente in rapporto al contenuto manifesto e assumerà, come direbbe Bion, l'aspetto di una narrazione; d) creazione di un fine a questo processo di pensiero che è la soddisfazione allucinatoria del desiderio istintuale.
Elementi beta non trasformati o alfa non ordinati possono rimanere anche in fase REM ed essere evacuati come scariche neurovegetative (Hautmann, 1977) o motorie. In questa linea interpretativa, gli stessi movimenti oculari rapidi potrebbero essere considerati come espressione di una evacuazione di elementi beta, un epifenomeno cioè che si realizza a carico di una muscolatura altamente specializzata la cui attività sarebbe aspecifica e non direttamente correlabile con il vissuto allucinatorio del sogno.
Il destino degli elementi beta nella fase di addormentamento merita un discorso a parte.
Essi infatti, per l'acuta deafferentazione sensoriale, raggiungono un'alta concentrazione nell'apparato mentale e anche se in parte sono evacuati come allucinazioni o mioclonie, in piccola parte possono andare incontro a una rapida organizzazione da parte della funzione alfa residua della veglia. Questo processo spiega i brevi sogni descritti all'addormentamento da vari autori (Fischer, 1965; Foulkes, 1966; Bosinelli e Molinari, 1968) e che per alcuni analisti (Slap, 1977) sono da considerare del tutto simili a quelli che occorrono in fase REM.
Per rimanere in linea con il pensiero di Bion propongo di usare la Griglia nel tentativo teorico di far rientrare gli eventi descritti entro la classificazione proposta da Bion (1963) per gli eventi mentali e non.
Come è noto l'ascissa della griglia rappresenta l'uso che l'apparato mentale o neurofisiologico può fare delle diverse categorie o enunciati considerati come trasformazione di una determinata esperienza. L'ordinata indica invece la classificazione dell'enunciato fino a una costruzione teorica molto elevata. Per questo dall'alto verso il basso è rappresentato nella griglia un grado crescente di complessità del pensiero (Grinberg e coll., 1973).
Se immaginiamo il sonno come un fenomeno che dall'addormentamento alla fase REM subisce un progressivo crescente aumento di complessità, possiamo ipotizzare che il pensiero della veglia, destrutturato dalla deprivazione sensoriale acuta nelle fasi non-REM, trovi posto nella categoria A, in quanto formato essenzialmente da elementi beta e occupare le caselle da Ai= An. Infatti la dissoluzione della barriera di contatto produce elementi beta in notevole quantità che dalla colonna A, come semplici significanti possono andare incontro a diverso destino: possono cioè essere espulsi per le vie sensoriali o motorie e appartenere in questo caso alla colonna A, o andare incontro a diversa elaborazione ed entrare così nelle caselle A, As, Ar.
[...]
Il destino più naturale degli elementi alfa è di organizzarsi nel sonno REM in funzioni alfa del sogno ed entrare quindi a far parte della categoria C. Anche nel sogno gli elementi alfa possono appartenere alle diverse caselle da C=-Cn: a seconda del grado di elaborazione gli elementi che diventeranno parte della narrazione del sogno e del suo contenuto entreranno nelle caselle Ci=C. Alcuni elementi invece possono usare in questa fase di sonno le vie motorie o vegetative ed entrare quindi nella casella C. In questa casella potrebbero essere incluse le modificazioni cardiocircolatorie e respiratorie e gli stessi movimenti oculari rapidi, che hanno così tanta importanza nel definire lo stadio e, in età evolutiva, nel definire il grado di maturità raggiunto dal sistema nervoso centrale.
Per concludere, ho fatto qui un tentativo di definire un tracciato neurobiologico entro il quale fare entrare concetti nati dalla pratica clinica e da riflessioni teoriche.
Il concetto di funzione alfa di Bion e l'uso che egli ha fatto della Griglia suggeriscono un modello che, nella elaborazione di operazioni mentali, si avvicina al modello biologico. In questo senso ho creduto di poter definire Bion un dualista-interazionista, su posizioni diverse da Popper e Eccles, ma pur sempre su quella linea di pensiero che potrebbe riallacciarsi al primo Freud del Progetto.
Le funzioni della mente per Bion, si esplicano infatti all'interno di funzioni neurobiologiche che permettono alle operazioni mentali di strutturarsi e manifestarsi. Questo è particolarmente vero per le funzioni alfa del sogno che qui ho cercato di inserire nell'ambito di una attività o cornice biologica che faccia da « contenitore », per rimanere nel linguaggio di Bion, alla organizzazione dei processi del pensiero.