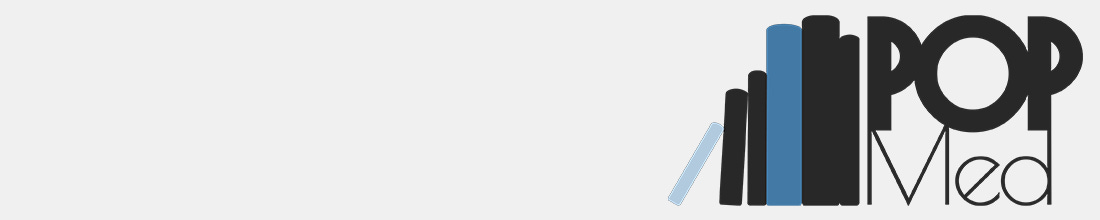MARZO, 2023: POPMed #10
Addentriamoci, insieme, nella giungla della letteratura scientifica, per tornare alla fonte!
Ciao a tuttə, siamo Raffaele Avico, Francesco della Gatta e Andrea Pisano.
Benvenutə su POPMed. Di che si tratta?
Di una newsletter a cadenza bi-settimanale pensata per proporti 10 articoli scientifici su ricerche, studi che crediamo possano essere rilevanti per le scienze cliniche del mentale (psichiatria, psicologia clinica, neuroscienze, avanguardie di ricerca, salute mentale). Saranno spesso in lingua inglese e daremo priorità ad articoli ad elevato impatto scientifico(meta-analisi e review, ma anche RCT), tutti free: 9 di questi saranno incentrati su aspetti di avanguardia, ovvero sviluppi recenti della letteratura mentre 1 articolo si riferirà invece a una ricerca di impatto storico nell’area scientifica di interesse.
Come mai questo progetto?
Cosa significa per noi tornare alla fonte?
Significa innanzitutto proporre - e promuovere - una (in)formazione diretta, ma graduata: potrai entrare in contatto con la complessità della letteratura scientifica, ma non da solo. Nella newsletter si trovano infatti: una sinossi introduttiva a ciascun articolo, una serie di approfondimenti specifici, il link diretto agli articoli per poterli consultare. Vorremo quindi essere delle lenti attraverso cui potervi affacciare con sicurezza a uno scorcio della letteratura scientifica esistente.
Tornare alla fonte significa anche promuovere un giornalismo scientifico di qualità e orientato al reale della pratica clinica: tenteremo infatti di proporvi studi con una ricaduta diretta sulla dimensione professionale.
Che tu sia quindi unə giovane interessato alla macro-area della salute mentale o unə professionista della cura, confidiamo questo progetto possa essere per te!
Se vuoi, aiutaci a farci conoscere. Parla di POPMed e vienici a trovare su Instagram (@_popmed)! Ti aspettiamo per tornare, insieme, alla fonte!
Buona lettura amicə!
1. Carcere, psicoterapia e recidive.
Il fenomeno della recidiva nelle persone rilasciate dal carcere è rimasta elevata per molti decenni. Per affrontare questo problema, i trattamenti psicologici sono stati sempre più utilizzati nei contesti della giustizia penale; tuttavia, ci sono poche prove sulla loro efficacia. Nella review e meta-analisi che vi proponiamo pubblicata sulla prestigiosa rivista The Lancet Psychiatry, gli autori hanno mirato a valutare l'efficacia degli interventi in carcere per ridurre la recidiva dopo il rilascio. Qui ti invitiamo a rispolverare le peculiarità della gerarchia nella letteratura scientifica. In generale, sembrerebbe che gli interventi psicologici ampiamente implementati per le persone in carcere per ridurre i reati dopo il rilascio debbano essere migliorati. Il bias di pubblicazione e gli effetti di piccoli studi sembrano aver sovrastimato i modesti effetti riportati di tali interventi, che non erano più presenti quando nelle analisi venivano inclusi solo studi più ampi. I risultati suggeriscono che le comunità terapeutiche e gli interventi che assicurano la continuità dell'assistenza in contesti comunitari dovrebbero essere prioritari per la ricerca futura e che lo sviluppo di nuovi trattamenti dovrebbe concentrarsi sull'affrontare i fattori di rischio modificabili per la recidiva. Qui trovi un breve video che tocca molti aspetti della complessità del processo di re-inserimento in società. Gli autori, infine, domandandosi come mai l’efficacia di tali trattamenti in carcere sia così scarsa, individuano alcuni elementi chiave. In primo luogo, gli interventi in carcere potrebbero non essere efficaci a meno che non siano collegati ad interventi mirati ai bisogni psicosociali delle persone rilasciate. In secondo luogo, la maggior parte degli interventi testati sono stati sviluppati nella comunità o nelle popolazioni cliniche per altri esiti, e quindi potrebbero non affrontare i fattori di rischio specifici della recidiva. Tali fattori di rischio devono essere identificati da una valutazione di alta qualità e quindi collegati a interventi per ridurre la recidiva. Una terza implicazione riguarda la terapia cognitivo comportamentale (CBT). L'assenza di effetto che gli autori hanno riportato è diversa dalle prove di alcune revisioni che hanno suggerito che la CBT è una delle forme di trattamento più efficaci per le persone in carcere. Tuttavia, gli autori segnaliamo effetti modesti, nella migliore delle ipotesi, per gli interventi psicologici erogati in carcere. In conclusione, dovrebbero essere considerate prioritarie le sperimentazioni di interventi di comunità terapeutiche e relativi approcci che facilitano la continuità del trattamento dopo il rilascio dal carcere. Considerando gli alti tassi di recidiva e le conseguenze per la salute e la sicurezza pubblica, sono necessari RCT semplici e ampi sull'efficacia degli interventi psicologici in carcere.
Eccovi l’articolo:
Effectiveness of psychological interventions in prison to reduce recidivism: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials.
2. Stereotipi di genere e giudizi sociali, nei bambini?
I bambini piccoli tendono a classificare persone e oggetti per comprendere i loro ambienti, ma in determinate circostanze possono anche apprezzare le differenze individuali. La ricerca che vi proponiamo racchiude tre studi che hanno esaminato il modo in cui i bambini usano le informazioni categoriche e individuali per formulare giudizi sociali. Nello Studio 1, i bambini di età compresa tra 3 e 5 anni (N = 33; 18 maschi, 15 femmine) hanno predetto le preferenze ipotetiche dei coetanei per i giocattoli lungo uno spettro da altamente stereotipato per le ragazze a neutro a altamente stereotipato per i ragazzi. Le scelte dei bambini erano coerenti con l'uso delle informazioni individuali fornite piuttosto che con il solo genere. Negli studi 2 e 3, gli autori hanno testato nuovamente la stessa ipotesi con campioni prescolari rispettivamente degli Stati Uniti (N = 44) e della Cina (N = 21), chiedendo inoltre ai bambini le loro preferenze in termini di giocattoli, compagni di gioco e attività. Per entrambi i campioni, le risposte erano caratterizzate da preferenze per i coetanei dello stesso sesso e giocattoli e attività neutri o di genere, in particolare nelle ragazze. Mentre i bambini piccoli esprimono preferenze coerenti con l'identità di genere, elaborano e utilizzano le informazioni individuali per formulare giudizi sociali, una capacità che potrebbe essere presa di mira da interventi progettati per ridurre lo sviluppo di pregiudizi basati sul genere. Qui trovi una breve intervista a Umberto Galimberti in cui parla dell’importanza del coltivare una cultura emotiva fin dalla tenera età. Se gli stereotipi di genere sono particolarmente salienti nelle scelte dei bambini, allora una strategia efficace per l'intervento potrebbe puntare allo smantellare, ampliare o aumentare la flessibilità di questi schemi. Tuttavia, se i bambini prestano attenzione almeno in parte all'individualità delle informazioni, un ulteriore approccio potrebbe essere quello di capitalizzare tale tendenza con una maggiore attenzione alla natura sfaccettata degli interessi individuali. Un tale approccio enfatizzerebbe la complessità degli individui e aumenterebbe la resistenza alla categorizzazione di sé e degli altri, in particolare quando si formulano giudizi sociali. Gli autori concludono che dato che gli stereotipi di genere sono all'inizio del processo di formazione ed espansione nel corso degli anni prescolari, questo periodo di sviluppo potrebbe essere l'ideale per l'intervento.
Eccovi l’articolo:
Toy stories: Children's use of gender stereotypes in making social judgments.